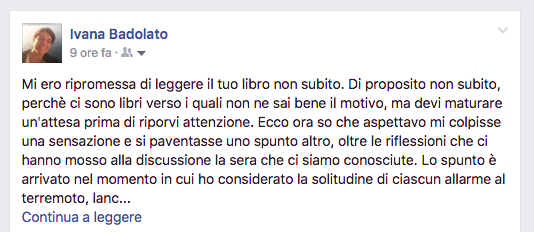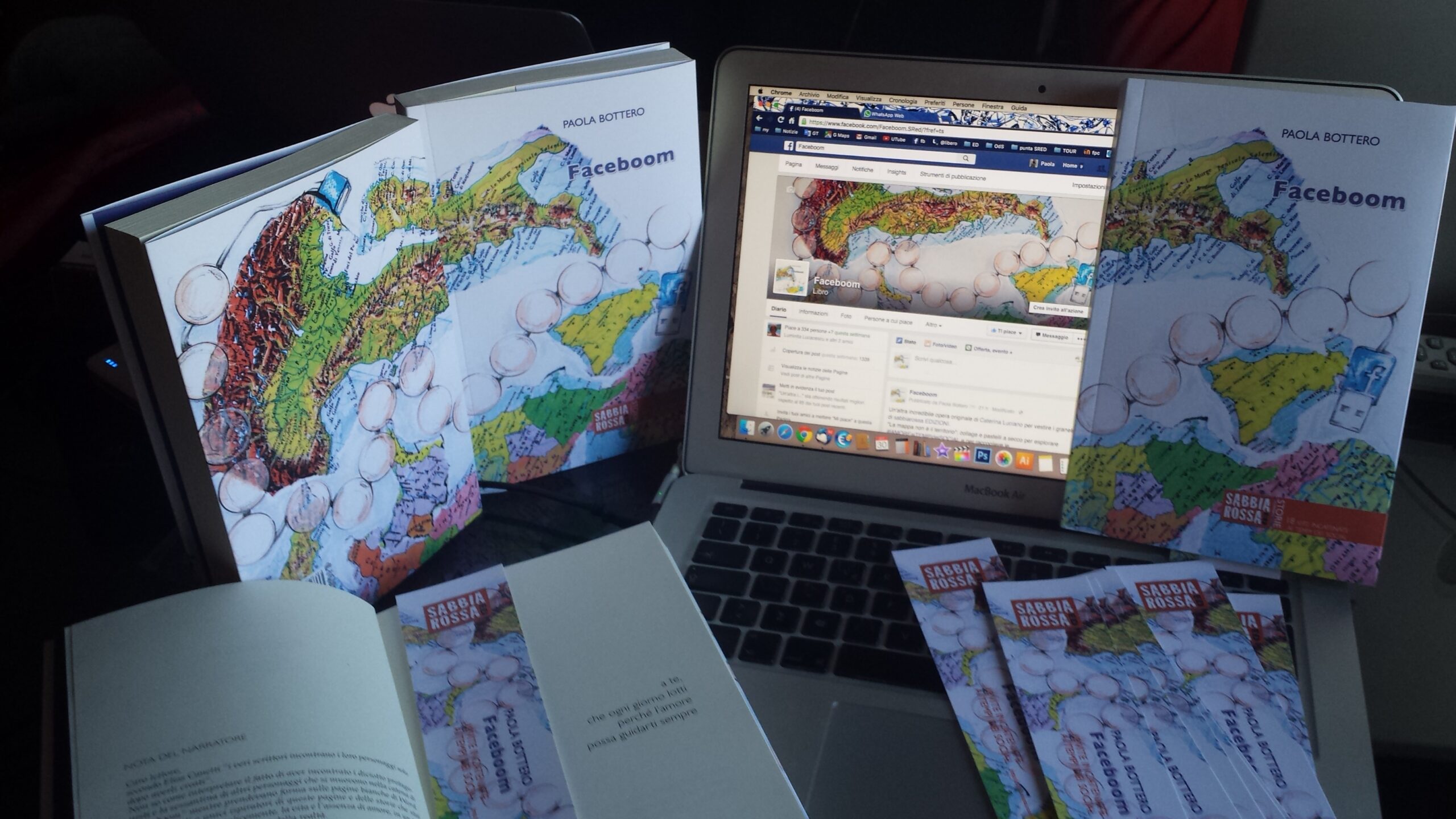di Laura Cirella | scirocconews
Ci sono almeno due modi per approcciarsi a Sono un ragazzo di paese, l’ultima creazione letteraria di Nino Mallamaci. La modalità di chi si approccia alla vita dell’amico Nino, che già conosce, con il suo fare rilassato e sornione, provocatorio e ironico, con le sue vicende più o meno paradossali o tragicomiche. Chi lo conosce, che ne è amico, sa già quanto sia spericolato alla guida, quanto sia attratto dal gentil sesso di bell’aspetto, quanto sia padre smisuratamente innamorato e quanto sia orgoglioso, a buona ragione, della sua storia personale e familiare. In tal senso il suo “libriccino”, come lui stesso lo definisce, ancora una volta teneramente simpatico verso sé stesso, non sarà altro che una conferma, una eclatante conferma, di chi è Nino Mallamaci, del suo spirito autentico e spudoratamente schietto. Chi gli vuole già bene gliene vorrà di più, perché ogni rigo è pura espressione del suo carattere e del suo stile di vita.
Vi è poi una seconda modalità per nulla scontata: quella puramente narrativa e letteraria. Seguendola il “libriccino” può rivelarsi ben più potente e con vocazione meditativa. Il “paese” di Nino Mallamaci si trasforma in uno stato d’animo che, a ben guardare, al giorno d’oggi, abbiamo del tutto smarrito. Oggi, immersi nella tentacolare rete senza limiti geografici del web e dei social network, non disponiamo più di quello stato d’essere ascrivibile a un luogo. Il “paese” di Nino, così come per altri il quartiere, il condominio, la città in cui si è fatta l’università…, è un limite geografico ormai smarrito che offriva orizzonti relazionali arcaici, forti, potenti. La tenerezza smisurata degli affetti, gli odori legati indissolubilmente ai ricordi, la semplicità dei giochi d’infanzia, un lessico famigliare che richiama una Calabria pietrosa e afosa. Il “paese” è scandito da tempi lenti e liturgici (…ogni estate… ogni domenica… ogni Natale…), offre un rituale rassicurante e rarefatto, rotto, nel racconto di Mallamaci, dallo spirito rivoluzionario della sua gioventù, tra ribellione e sogni, tra ambizioni e desideri, rivelando una purezza d’animo come quella di un bambino, tra l’eccitazione per le novità e il perdurare degli affetti familiari. Così, anche quando Nino lascia il “paese”, lui resta un ragazzo di paese, nelle sue avventure in una quotidianità urbana che gli richiede forte spirito di adattamento, in una sfida continua alla sorte e alle leggi di Murphy. Nino sopravvive agli eventi che sopraggiungono con una autoironia esilarante, sarcasmo, senso dello humor e, a dire la verità, una piacevolissima verve letteraria. E se quella semplicità e quella genuinità “motticiana” sono ormai dentro il narratore per sempre e non lo abbandoneranno mai, idem quel senso del rigore, quell’inflessibilità di fronte a ciò che è ingiusto, quell’intolleranza nei confronti dell’intollerante, quel dover fare una cosa perché è giusto che si faccia, piaccia o non piaccia. La parola diviene pietra, il sentimento diviene valore etico irrinunciabile. Il paese per lui è radice e dunque il narratore non può che essere radicale, in ciò che fa e pensa.
Ma vi immaginate, dunque, se ognuno di noi avesse un paese a cui ispirarsi? Vi immaginate se avessimo ancora tutti la possibilità, almeno per un minuto al giorno, di tornare alle nostre radici?
Nel 1950, Cesare Pavese, ne La luna e i falò, scrive: “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.”
“Sono un ragazzo di paese” ci regala il gusto del viaggio dentro di noi, dell’abbandono e del ritorno alle nostre radici; lo fa in una maniera divertente, che ci lascia il sorriso stampato sulla faccia, senza angoscia e senza rimpianti, senza paturnie e senza recriminazioni, ma con quel piacere come di una buona lettura… all’ombra… al mare… in agosto.